संतोषाद् अनुत्तमः सुखलाभः ॥४२॥
saṅtoṣād anuttamaḥ sukhalābhaḥ ॥42॥
Dalla contentezza scaturisce la felicità suprema
 Saṅtoṣā è il secondo niyama descritto negli Yoga Sutra di Patanjali. Il termine deriva dal sanscrito sam, che significa “completamente” o “del tutto”, e “toṣā”, (pronunciato tosha), che significa “soddisfazione” o “accettazione”.
Saṅtoṣā è il secondo niyama descritto negli Yoga Sutra di Patanjali. Il termine deriva dal sanscrito sam, che significa “completamente” o “del tutto”, e “toṣā”, (pronunciato tosha), che significa “soddisfazione” o “accettazione”.
Saṅtoṣā è un atteggiamento. Se siamo abituati ad essere infelici e brontolare, rischiamo di essere infelici e brontolare anche nelle migliori situazioni.
Questo niyama ci insegna che la forza della felicità è misurata dal nostro atteggiamento davanti alle situazioni avverse. Se tutto va liscio, il nostro sorriso non vale nulla: dovremmo imparare a sorridere anche quando le nostre sicurezze vacillano o addirittura crollano.
Saṅtoṣā è una pratica. Essere felici incondizionatamente è una pratica. E dobbiamo svilupparla da soli, perché nessun altro può farlo per noi. Se qualcun altro o qualcos’altro ce la dà, sarà solo una felicità temporanea. 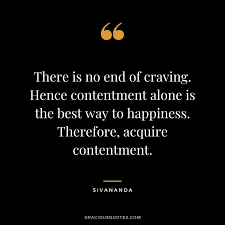
Saṅtoṣā è strettamente collegato con il primo niyama, śaucā. Quando Patanjali scrive che śaucā, la purezza, comporta l’abbandono della fisicità e la cessazione del contatto fisico con le cose esterne, intende che se siamo costantemente in contatto con altre persone, allora non permettiamo al nostro vero io di emergere e mostrarsi. Dal momento che siamo sempre in associazione con qualcun altro, ci perdiamo e non sappiamo chi siamo, non ci conosciamo. Per questo dobbiamo mantenere un po’ di distanza e un po’ di tempo per noi stessi: per imparare a conoscere qual è la nostra vera forza, qual è la nostra vera debolezza, qual’è la parte più pura e autentica di noi, quella che non può essere corrotta. Solo quando avremo sviluppato śaucā potremo scoprire saṅtoṣā, la vera contentezza.
Ma come fare, quando siamo sopraffatti da un’emozione forte?
Pensiamo alla tragedia della morte. Quando qualcuno muore, la miseria prende il sopravvento e quel periodo è chiamato aśaucā, nel senso che non c’è śaucā, non c’è purezza perché la mente è afflitta dalla tristezza. Quindi in India, i 10 giorni dopo la morte di qualcuno sono considerati aśaucā: per 10 giorni si può piangere, affliggersi, autocommiserarsi.
L’undicesimo giorno la famiglia si riunisce e festeggia, indossando abiti nuovi e scambiandosi doni: la vita continua. Addirittura, se muore una persona con un elevato piano spirituale, non c’è lutto nemmeno per un giorno. Ogni momento è una celebrazione perché lo spirito è onnipresente.
Allo stesso modo, pensiamo a un evento diametralmente opposto: la nascita di un bambino. Anche in questo caso c’è aśaucā per dieci giorni, perché siamo così euforici per la nuova anima che non siamo veramente presenti a noi stessi. Quindi si festeggia, si dimenticano tutti gli impegni, si gioisce e basta. All’undicesimo giorno, si torna presenti.
Ecco che la vera contentezza risiede in un equilibrio delle emozioni, non nell’euforia, che invece è temporanea. Ecco perché śaucā e saṅtoṣā vanno insieme. Se non c’è śaucā, non può esserci saṅtoṣā.
Buona pratica della contentezza a tutti!
